  09/04/2007 07:52 09/04/2007 07:52 |
|
|
Gli album che hanno fatto la storia del Rock !!!!!
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Columbia 1966) Folk-Rock
Jeff Buckley Grace (Columbia, 1994)Rock
Band - Music From Big Pink(Capitol 1968) Country-folk
Deep Purple - Made in Japan (Emi 1972) Hard -Rock
Janis Joplin - Pearl (Columbia 1970) Blues Rock
The Beatles - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (Emi 1967)Pop
Van Morrison - Astral Weeks (Warner 1968) Pop Rock
Clash - London Calling(Cbs 1979) Punk
Talking Heads: 77 (Sire, 1977)
Morphine - Cure For Pain (Rykodisc, 1993)
Frank Zappa - Hot Rats (Bizarre 1969)Rock
[Modificato da ziva 13/10/2007 16:03] |
|
  09/04/2007 07:53 09/04/2007 07:53 |
|
|
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Columbia 1966) Folk-Rock 
Tracklist
1.Rainy day women nos 12 & 15
2.Pledging my time
3.Visions of Johanna
4.One of us must know (sooner of later)
5.I want you
6.Stuck inside of mobile with the Memphis blues again
7.Leopard-skin-pill-box hat
8.Just like a woman
9.Most likely you go tour way and I'll go mine
10.Temporary like Achilles
11.Absolutely sweet Marie
12.4th Time around
13.Obviously 5 believers
14.Sad eyed lady of the lowlands
Festival folk di Newport del 1965: Bob Dylan, il giovane folksinger più amato d'America, si presenta all'appuntamento accompagnato da 3/5 della Paul Butterfield Blues Band (compreso l'eccezionale chitarrista Mike Bloomfield), e inizia a lanciare bordate di musica elettrica sull'attonito pubblico, composto in massima parte da puristi del folk. In pochissimo tempo il palco diventa un campo di battaglia e Dylan è costretto ad andarsene dopo tre pezzi.; tornerà pochi minuti dopo per intonare, in rigorosa versione acustica, una profetica "It's all over now, baby blue".
Nonostante il diluvio di critiche che gli piovono addosso, Dylan porta avanti la svolta elettrica e nel settembre del 1965 incide "Highway 61 revisited", eccitante album di blues elettrico (a parte gli undici minuti acustici di "Desolation Row"), e si imbarca in un massacrante tour mondiale, che in più di un'occasione sfocia nello psicodramma collettivo. Tra le pause del tour nasce "Blonde on Blonde", capolavoro insuperato dell'arte dylaniana, nonché snodo fondamentale nell'evoluzione della musica rock.
"Blonde on blonde" è il primo album doppio della storia, in anticipo di qualche mese su "Freak Out" di Frank Zappa, e segna il definitivo passaggio dall'era del 45 giri a quella del 33 giri; dopo "Blonde on blonde", l'album non potrà più essere concepito né come una banale raccolta di singoli, né tantomeno come una serie di riempitivi che fanno da contorno all'hit single di turno, ma diventerà il frutto unitario, indivisibile nelle sue parti, della mente e dell'anima dell'artista. Nasce di fatto la magica stagione dei concept album.
Ma la vera rivoluzione copernicana Dylan la compie sui testi, fino a quel momento il punto debole della musica rock, che abbandonano il registro della canzone di protesta e diventano ermetici, metafisici e visionari. Le canzoni di "Blonde on blonde" parlano d'amore, ma lo fanno attraverso una cascata di citazioni e riferimenti che vanno da Shakespeare a Platone, dalla poesia simbolista di Rimbaud alle vecchie canzoni dei pionieri dei monti Appalachi; inoltre, molto spesso le liriche nascono da libere associazioni mentali di immagini (emblematica in questo senso "Visions of Johanna"), e hanno un tono colto e intellettuale davvero inconsueto per l'epoca.
Da un punto di vista musicale, con "Blonde on blonde", registrato a Nashville con l'ausilio di musicisti del calibro di Robbie Robertson e Al Kooper (il suo organo è il protagonista assoluto del disco), Bob Dylan assimila definitivamente la lezione folk-rock dei Byrds, sviluppa il blues elettrico di "Highway 61 revisited" e getta un ponte verso le nuove istanze psichedeliche.
Si parte con l'incedere caracollante di "Rainy day women nos 12 & 15", sorta di blues degli svitati con tanto di trombe da circo Barnum, voci sguaiate in sottofondo e un Dylan più sfasato che mai; il testo, censurato un po' ovunque, propone doppi sensi che rimandano al consumo di droga (la locuzione "Rainy day women" sta a indicare il nostro "spinello"). Il menestrello di Duluth è ormai morto e sepolto. Un'armonica stridente introduce il lento e viscerale blues "Pledging my time", che sembra uscito direttamente dai solchi di "East-West" della Paul Butterfield Blues Band. In "Visions of Johanna", Dylan, come Alice, passa attraverso lo specchio e si lascia andare al flusso di coscienza; le visioni d'amore allucinato delle cinque strofe del testo e il visionario accompagnamento dell'organo di Kooper si insinuano subdolamente nei labirinti della mente e gettano l'ascoltatore in un sublime stato di trance ipnotica. Indubbiamente il capolavoro dell'album, un volo pindarico dell'immaginazione verso l'infinito.
La successiva "One of us must know (sooner or later)" regala uno dei momenti più intensi del disco, grazie ai ricami della sei corde di Robbie Robertson e alle folate dell'organo, prima di esplodere nell'anfetaminico ritornello. L'orecchiabile e briosa "I want you" (il brano di maggior successo dell'album) è bella, colorata e ricca di suggestioni, come un arcobaleno dopo un pomeriggio di pioggia. Sullo stesso registro ironico di "Rainy Day women nos 12 &15", si muove "Leopard-skin pill-box hat", scatenato omaggio ai padri fondatori del rock 'n roll. "Stuck inside of mobile with the Memphis blues again" è una delle apocalittiche gallerie dylaniane di varia umanità, sulla scia di "Desolation Row".
Si prosegue con la dolce "Just like a woman", classica ed elegante ballata folk-rock basata su un semplice giro di chitarra e puntellata dai tocchi del pianoforte e dal discreto organo di Kooper; nel testo, Dylan ironizza sull'altra metà del cielo, il che gli procurerà non pochi problemi con il nascente movimento femminista. La leggiadra "Just like a woman" lascia il posto al vibrante blues di "Most likely you go your way and I'll go mine", desolato dialogo tra due innamorati giunti al capolinea della loro storia.
Uno dei vertici compositivi di "Blonde on Blonde" è sicuramente la scoppiettante "Absolutely sweet Marie" , lanciata in orbita dal maestoso riff dell'organo di Al Kooper e dall'incedere fluido della strumentazione, con in particolare evidenza il bel lavoro di Kenneth Buttrey alla batteria. L'arpeggio di chitarra in stile Tex-Mex conferisce un clima di estatica serenità a "4th time around", stralunata successione di bozzetti allegorici.
L'ideale quarta facciata del disco è interamente occupata dagli 11 intensissimi minuti di "Sad eyed lady of the lowlands", che, a modesto parere di chi scrive, è semplicemente la più bella canzone d'amore della storia della musica popolare: una struggente serenata folk di disarmante e geniale semplicità, che lascia segni profondi nell'anima. Per descrivere il brano, faccio mie le straordinarie parole del critico rock Paul Nelson, che di "Sad eyed lady of the lowlands" disse: "Una celebrazione della donna come opera d'arte, come figura religiosa, come oggetto di eterna maestà e meraviglia".
Così cala il sipario su un album straordinario, che negli anni diventerà l'ossessione di tutti i cantautori del globo, e che, soprattutto, rimane una preziosa testimonianza di come la musica rock possa trasformarsi in arte con la A maiuscola.
di Andrea Fedeli
http://www.ondarock.it/pietremiliari/dylan_blonde.htm
|
  10/04/2007 19:49 10/04/2007 19:49 |
|
|
Jeff Buckley Grace (Columbia, 1994) 
Jeff Buckley Grace (Columbia, 1994)
Mojo Pin / Grace / Last Goodbye / Liliac Wine / So Real / Hallelujah / Lover, You Should’ve Come Over / Corpus Christi Carol / Eternal Life / Dream Brother
Pubblicato nell’agosto del 1994
Prodotto e mixato da Andy Wallace
Registrato ai Bearsville Studios di Woodstock, New York
Art direction & design: Nicky Lindeman, Christopher Austopchuk
Foto di copertina: Merri Cyr, David Gahr
Musicisti: Jeff Buckley (voce, chitarra, harmonium, organo, dulcimer e tablas in Dream Brother); Mick Grondahl (basso); Matt Johnson (batteria, percussioni e vibrafono in Dream Brother); Michael Tighe (chitarra in So Real); Gary Lucas (‘magicalguitarness’ in Mojo Pin e Grace); Loris Holland (organo in Lover, You Should’ve Come Over); Misha Masud (tablas in Dream Brother); Karl Berger (arrangiamento d’archi).
È un’opera particolare, Grace. Difficile da valutare con lo stesso metro di giudizio che usiamo abitualmente per tutti gli altri album. Non è un disco perfetto, se per perfezione si intende grande attenzione ai particolari formali e qualità delle composizioni sempre eccellente. Ci sono peccati di ingenuità, ma c’è anche una sensibilità straordinaria che illumina tutte le composizioni, una ‘grazia’ unica e irripetibile. In queste dieci canzoni Jeff Buckley è riuscito ad esprimere quello che tutti vorremmo comunicare, le mille parole che ci piacerebbe dire al mondo e che non riusciamo a tirare fuori, che ci rimangono strozzate in gola o, peggio ancora, che per vigliaccheria ci teniamo per noi. Eppure, secondo le parole dello stesso Buckley, "essere sensibili non significa essere deboli. Significa essere dolorosamente consci del fatto che una mosca che si posa sulla schiena di un cane possa fare un rumore simile ad uno scoppio supersonico".
Inizia presto ad ascoltare musica, il giovane Jeff. Comincia presto anche a suonare e a scrivere le sue canzoni. Eppure arriva al debutto sulla lunga distanza solo a 27 anni. In pratica inizia da dove aveva smesso il padre Tim (morto proprio all’età di 27 anni, però dopo aver pubblicato ben otto album). Un modo per raccogliere il testimone del celebre genitore? Nemmeno per sogno. Cerca in tutti i modi di nascondere la sua vera identità e non parla mai, ma proprio mai, del padre.
Hal Willner nel 1991 organizza a New York un concerto-tributo a Tim Buckley. Informato sull’esistenza di un figlio che è anche un cantante lo rintraccia e gli chiede di partecipare alla serata. Jeff, che al tempo era praticamente sconosciuto, sale sul palco senza essere presentato come figlio di Tim e interpreta tre canzoni del repertorio del padre: I Never Asked To Be Your Mountain, Once I Was e The King’s Chain. Tutti i presenti in sala capiscono immediatamente che qualcosa sta succedendo, i più attenti non tardano molto a riconoscere nel timido ragazzo sul palco il figlio del grande Tim Buckley: stessa voce, stesso timbro, stessa intensità, stessi lineamenti del viso. Solo i capelli sono diversi, Jeff non ha i grandi ricci del padre, per il resto la somiglianza è davvero stupefacente. Chi assiste a questa performance comprende anche un’altra cosa: cioè che una nuova stella è già pronta a risplendere nel cielo del rock.
Jeff arriva al primo album dopo anni di militanza in locali suonando prevalentemente cover (il mini-album Live at Sin-é rimane una fedele testimonianza di quel periodo); non è un caso quindi che ben tre brani sui dieci contenuti in Grace siano delle riletture.
Il processo di avvicinamento alla registrazione è insolitamente lungo. Prima individua in Andy Wallace l’uomo giusto per occuparsi della produzione, poi dallo stesso Wallace si fa consigliare per la scelta degli studi. Alla fine decidono insieme per i Bearsville Studios di Woodstock (luogo che a distanza di trent’anni rimane una sorta di città sacra per il rock), fuori dalla mischia della Grande Mela, ma abbastanza vicino da poterci tornare senza troppa fatica all’occorrenza. Ma la ricerca più lunga e faticosa diventa quella per reperire i musicisti giusti. Buckley capisce subito che non dovranno essere i soliti turnisti, virtuosi dello strumento che passano da uno stile ad un altro, da un disco all’altro, con distacco e senza essere coinvolti emotivamente in nessun progetto. Il giovane Buckley ha bisogno di persone capaci di entrare in sintonia con il progetto, non solo, devono essere preferibilmente anche amici (non a caso in due degli scatti poi inseriti nel libretto si fa immortalare insieme al resto della band, fatto poco usuale per un solista). Con questo criterio arriva a selezionare tre persone diversissime tra loro: Matt Johnson è ben inserito nella scena newyorkese, Mick Grondhal in realtà segue i concerti di Jeff e si innamora della sua musica, infine Michael Tighe è l’unico che Jeff conosce da tempo.
Il lavoro in studio è per buona parte già organizzato prima di iniziare. Grace diventa da subito un riassunto del periodo della carriera artistica di Buckley: sono pochi i brani composti per l’occasione, la maggior parte risale a un periodo compreso tra il 1990 e il 1993. Mojo Pin ed Eternal Life si possono trovare in Live at Sin-é (si tratta di canzoni scritte insieme a Gary Lucas al tempo del progetto aperto chiamato Gods And Monsters), mentre canzoni come Grace, Last Goodbye e Lover, You Should’ve Come Over sono già conosciute dal pubblico che ha potuto assistere alle esibizioni live del giovane Buckley. Resta quindi da scegliere quali cover inserire e completare l’album con un paio di pezzi nuovi, apparentemente un compito semplice e veloce, e invece le registrazioni, cominciate nel settembre del 1993, si protraggono fino all’inizio dell’anno nuovo. Per Jeff, come è naturale che sia, il lavoro in studio è un’assoluta novità, ma anche la band inizia a trovare una propria misura solo dopo qualche tempo. Le session sono già completate, ma è scattato il meccanismo che porta un gruppo di musicisti a continuare senza sosta, solo per il piacere di suonare.
L’album si apre con Mojo Pin, uno dei vertici drammatici dell’opera con la voce di Jeff in primissimo piano, inizia come un sussurro, una carezza, per poi salire in alto là dove nessun altro può aspirare ad arrivare. Un brano che cresce, si ferma, riparte, per poi terminare in un vortice di voce e chitarre, in un certo senso rappresenta in maniera efficace l’intero album: c’è tutto e il suo contrario. Il brano che dà titolo all’album raddrizza subito dopo il tiro, ora è evidente che la voce conquista non tanto e non solo per la sua estensione, quanto piuttosto per l’incredibile forza espressiva. Lover, You Should’ve Come Over è il prototipo della composizione aperta che tanto affascinava Jeff. Alla fine Wallace riesce ad imporsi e costringe Buckley a ridurre la durata del pezzo da una decina di minuti (a tanto arrivava nei concerti) a soli, si fa per dire, sei minuti e quarantadue secondi. Last Goodbye invece testimonia lo sforzo compiuto per rimanere dentro i confini della classica canzone pop, un pezzo ordinario, se messo a confronto con la complessità degli altri episodi, eppure proprio nella sua semplicità risiede la sua forza e la sua efficacia. In questa occasione gli arrangiamenti per archi curati da Karl Berger aggiungono spessore ad un impianto già di per sé notevole. Eternal Life apre a un aspetto più duro e diretto della musica, quello che poi Buckley sceglierà di approfondire con il contributo di Tom Verlaine nel seguito di Grace (il disco uscirà postumo con il titolo Sketches For My Sweetheart The Drunk).
Infine, non esistono frasi adatte per descrivere le interpretazioni di Liliac Wine e di Hallelujah. Proprio questi due gioielli fanno ritornare in mente le parole di Lee Underwood riferite al padre di Jeff: "Tim Buckley ha fatto per la voce quello che Hendrix ha fatto per la chitarra, Cecil Taylor per il piano e John Coltrane per il sax". Jeff si avvicina a questi due brani attraverso vie traverse, si appassiona alla versione di Liliac Wine offerta da Nina Simone, mentre per Hallelujah non prenderà a modello l’originale di Leonard Cohen quanto piuttosto la struggente versione per solo piano e voce offerta da John Cale in Fragments For A Rainy Season.
Nella bellissima foto di copertina Jeff tiene in mano un microfono e rivolge lo sguardo in basso come a voler nascondere qualcosa, eppure in queste dieci canzoni ci racconta il dolore, la grazia, la passione, la gioia, la compassione, la spiritualità. Tutto, insomma.
C’è in questo disco il coraggio di un uomo pronto a scendere fino al punto più profondo dell’abisso, c’è anche una tensione al rischio propria di coloro che non si vogliono fermare di fronte a nulla. Neppure di fronte ad un vortice nel canale di Memphis: "Ecco che viene la mia ora, non ho paura di morire" (da Grace). (EP)
www.jamonline.it/ |
  18/04/2007 17:38 18/04/2007 17:38 |
|
|
Band - Music From Big Pink 
Band -Music From Big Pink(Capitol) 1968 country-folk
di Ariel Bertoldo
Tracklist:
Tears of Rage
To Kingdom Come
In A Station
Caledonia Mission
The Weight
We Can Talk
Long Black Veil
Chest Fever
Lonesome Suzie
This Wheel's on Fire
I Shall Be Released
Da qualche parte, nel bel mezzo dello sterminato archivio fotografico di Elliott Landy, riposa un vecchio scatto in bianco e nero. Impolverato e seducente, reclama un posto d'onore, ma anche un nascondiglio, per essere scoperto e vissuto con la sorpresa che merita. L'immagine è stata scattata nella campagna di Woodstock, a West Saugerties, stato di New York, nel 1968.
Una fatiscente panchina di legno è al centro dell'obiettivo: potrebbe accogliere al massimo tre persone, sedute pure scomode.
Quella mattina ce ne sono ben cinque, ritratte di spalle, mentre ammirano meditabonde lo spettacolo naturale che si para loro innanzi: un laghetto limpido e il sole mattutino che ne rischiara il manto argenteo. Sull'altra sponda, ancora terra, alberi spogli per l'inverno, le Catskill Mountains a chiudere l'idilliaco panorama. Quei cinque potrebbero essere stanchi cercatori d'oro usciti da un romanzo di Mark Twain, oppure giovani agricoltori vestiti di tutto punto nell'attesa di un domani migliore, come gli orgogliosi reietti di William Faulkner, John Steinbeck e Walt Whitman.
Invece sono musicisti, e stanno incidendo il loro disco d'esordio.
Un piccolo passo indietro
Ronnie Hawkins, cantante e pianista dell'Arkansas, è rocker ambizioso e arrogante, istrione di modesta fama e discrete qualità artistiche. Folgorato dalla black-music, ha abbandonato l'università e, per la prima volta, in un club dell'Oklahoma (1957) avuto modo di vedere e unirsi a una band di soli neri, i Black Hawks.
La prima registrazione ufficiale esce nel '58 da un polveroso garage col titolo di "Hey Bo Diddley" e la sigla Ron Hawkins Quartet. Alla batteria siede il conterraneo Levon Helm, allora diciassettenne: il primo elemento chiave di quella che si chiamerà Band arriva dal profondo sud, testimone oculare di mille spettacoli di strada ( minstrel shows ), dei concerti di Elvis Presley (prima della fama) o Bill Monroe o Sonny Boy Williamson. Sarà lui il motore di tante storie rurali, lui la fonte d'ispirazione delle fiabe narrate da Robbie Robertson. Ribattezzata definitivamente Ronnie Hawkins & The Hawks, la band incide per la Roulette i primi due album, un omonimo del '59 e "Mr. Dynamo", soprannome del Nostro, l'anno successivo. La mossa vincente, strategica, è pero un'altra: spostarsi dal circuito degli squallidi bar e locali della zona di Memphis e andare a nord, verso il Canada. Da quelle parti si vendono molti meno idoli rock n'roll, c'è meno concorrenza e una tardiva voglia di certa gioventù di scuotersi e ballare. Il gruppo, a bordo di una cadillac nera che sa di vecchia gang, trova ingaggi con facilità, un mare di ragazze e parecchie situazioni da rissa western aftershow.
La pesante routine di concerti provoca alcuni cambiamenti d'organico: uno dopo l'altro entrano tutti i futuri membri di The Band. Robbie Robertson (dal 1960) alla chitarra solista e Rick Danko al basso, seguiti entro il Natale '61 dai tastieristi Richard Manuel e Garth Hudson. Purtroppo la carriera stenta a decollare e vive una svolta nell'unico effimero momento di gloria, una cover di "Who Do You Love" dell'amato Bo Diddley (1963). A quel punto la band di supporto lo abbandona e comincia a girare Canada e States con la nuova sigla Levon & The Hawks.
Una vera miniera di influenze diverse: rock 'n'roll ma anche rockabilly, country, blues, gospel e r&b. I cinque Hawks si influenzano a vicenda, tessendo progressivamente un mélange sonoro che di lì a poco cementerà un sound inconfondibile. Suggestive anche le biografie: Robertson, figlio di un giocatore d'azzardo ebreo (morto quando lui era bambino) e di un'indiana Mohawk, vissuto in una riserva di Toronto con le orecchie perennemente sintonizzate sulle onde radio di Nashville; Rick Danko poco più a nord, germogliato insieme ai campi di tabacco sulle rive del lago Simcoe; poi Manuel, con la sua ossessione per l'alcool e il canto di Ray Charles; quindi Hudson, organista/bimbo prodigio, miscelatore folle di Bach e Chuck Berry nell'impresa di pompe funebri di proprietà dello zio.
La musica, tutto un programma: da una parte la sezione ritmica, precisa e tuonante e solenne ed evocativa; dall'altra l'organo di Garth Hudson, il più adulto e preparato musicalmente (con studi classici alle spalle), ma anche carismatico sperimentatore di sonorità e arrangiamenti. Nel mezzo, il lavoro di chitarra di Robbie, serpeggiante come nessuno, virtuoso senza spocchia, appassionato sostenitore di paesaggi melodici atipici. Le voci: il meraviglioso falsetto romantico/solitario di Richard Manuel fa da contraltare all'allegria campagnola/grossolana dei fascinosi Danko e Helm.
In due anni di tournée da soli, cinque ora a notte, i ragazzi hanno la possibilità di incidere una manciata di singoli e, soprattutto, farsi ammirare su un palco (estate '64) dal deliziato John Hammond Jr. Quest'ultimo, figlio ventenne del leggendario talent scout della Columbia John Hammond, offre loro la chance di incidere con lui a New York, backing band di lusso per un modesto (ancora!) cantautore di blues bianco. Quei due album saranno il preludio all'incontro decisivo con Bob Dylan, durante la fatidica estate del 1965. Il quintetto lo conosce a malapena, distante da quella nuova estetica aggressiva, heavy ante litteram , che il cantautore propone. Eppure…
Il nanetto di Duluth è in quel mentre nuovo profeta folk, osannato con la stessa intensità da musicisti, fan, critica, addetti ai lavori, giovani e anziani.
"I tempi" però, "stanno cambiando", come lui stesso del resto aveva predetto: stanco della tradizione e della ballata di protesta, Bob imbraccia per la prima volta una chitarra elettrica e si crea una band di supporto, deciso a eguagliare (e in cuor suo superare) la scossa tellurica socio/musicale ispirata dai Beatles. Ecco allora "Bringing It All Back Home", primo successo milionario, e il "battesimo rock" sul palco del Newport Folk Festival alla fine di luglio, con Al Kooper, Mike Bloomfield e 3/5 della Butterfield Blues Band.
Il primo contatto reale con gli Hawks arriva grazie all'amicizia di Robbie Robertson, emissario degli Hawks, tra l'altro fortemente sponsorizzati alle orecchie di Bob da Mary Martin, segretaria del suo manager Albert Grossman.
Robbie si crea un ottimo rapporto con Dylan, divenendone compare inseparabile: da qui ad apparire al suo fianco nel concerto di Forest Hills (27/08), con Levon Helm alla batteria, il passo è breve. Due set distinti, uno acustico e l'altro (fischiato dai vecchi fan "puristi") elettrico e sferragliante. Bob è entusiasta e sceglie proprio gli Hawks (complice l'abbandono di Kooper, Bloomfield e Harvey Brooks) per continuare le date dell'estenuante, leggendario tour mondiale del '65/'66. Quel giro di concerti, interviste, proteste e fusi orari sfianca profondamente il fisico e gli animi dell'allegra brigata: Helm lascia quasi subito (fine novembre), in perenne disaccordo con un nuovo leader che ha progressivamente usurpato il suo prestigio di carismatico capo tribù.
E così, tra cambi di batteristi (da Bobby Gregg a Mickey Jones per la tranche europea) e fischi giornalieri dai nemici dell'elettricità, si chiude una delle più storiche tournée del rock, momento chiave nell'evoluzione del giocattolo che prende consapevolezza di sé. Il tragico incidente motociclistico di Dylan nella campagna di Woodstock (29/07/'66) fa il resto.
Il ricovero è prolungato e Bob preferisce restare in pianta stabile in quel "buen retiro" di campagna, lontano da anfetamine e giornalisti. Impone il silenzio artistico per un anno intero, crescendo figli con la compagna Sara. Poi, qualcosa si sblocca. Hudson, Danko e Manuel decidono di prendere in affitto una grande villa dipinta di rosa (ribattezzata appunto "Big Pink") nelle vicinanze, e adibirne la spaziosa cantina a sala di registrazione/rifugio musicale. A pochi chilometri c'è la magione di Albert Grossman, con Robbie e consorte ospiti fissi, mentre Helm va e viene dal sud. Da quella quiete bucolica prendono forma i demos dylaniani in seguito editi col nome di "Basement Tapes" e, soprattutto, il materiale per il debutto col nuovo nome: The Band. L'atmosfera è pigra e rilassata, il clima mite permette piccole escursioni collettive nella macchia circostante, gite e lunghe chiacchierate con i vicini di casa, tra un picnic e una partita di football.
Il resto dell'avventura
La prima cosa che stupisce il pubblico rock è proprio il contenuto del disco d'esordio della Band (1/07/68, n. 30 nelle chart Usa), distante miglia da ciò che si era abituati a sentire sino a quel momento: non ci sono raga indiani, né brani lunghi dieci minuti o riferimenti a droghe che espandono la mente. In "Big Pink" non trovano spazio abiti sgargianti o strumenti etnici. I termini "virtuosismo", "solipsismo", "divismo" sono banditi dal vocabolario. Al contrario, ciò in cui gli ascoltatori (curiosi all'inizio più della presenza/evento di Dylan che altro) si imbattono è una "bittersweet celebration of old & young americas". La storia nascosta dietro quella strana copertina ad acquerello (regalo di Bob, accreditato in tre brani) riguarda il presente letto con gli occhi del passato, odora forte di vecchio west, cowboy e indiani, di Grande Depressione e ampi spazi aperti, senso di appartenenza e anelito all'evasione.
Nulla, neanche dieci anni di "professionismo" alle spalle, avrebbe lasciato pensare a un affresco così spettacolarmente nitido, da ascoltare parecchio prima di essere assimilato. C'erano le premesse, c'era il background . Dylan aveva preparato la strada col suo criptico "John Wesley Harding", registrato con musicisti locali a Nashville e uscito l'inverno precedente. In "Big Pink" c'è un collettivo in assoluta confidenza con i propri mezzi tecnici, con tutti i diversi linguaggi musicali imparati nel tempo (country, folk, blues, gospel, rock, soul, r&b), con un songwriting finalmente maturo. Più di tutto, una conoscenza profonda dell'America, dei suoi vizi e virtù, analisi rese acute e possibili grazie anche alla privilegiata prospettiva "esterna" di questi canadesi speciali, più statunitensi degli stessi nativi. I temi chiave dell'album sono la famiglia, la fede, l'amicizia, la discendenza, la libertà di scelta e la voglia di fuggire da un ordine schematico e precostituito. La guerra è lontana eppure presente sullo sfondo: la tragedia e l'ansia sono palpabili attraverso quei testi sfuggenti, enigmatici. Dalla musica si percepisce un sensazione di libertà, di jam session svagata tra vecchi amici polistrumentisti che scambiano le parti vocali come fossero spinelli: "Big Pink" è il frutto di cinque personalità fuse in una sola, cinque diverse visioni della patria compenetrate l'una con l'altra.
Sono undici canzoni che vanno dritte al cuore, che commuovono per semplicità, sincerità e immediatezza esecutiva. Il dialogo, il mettere in discussione le proprie radici si dimostra impegno populista che, alla lunga, finirà per influenzare parecchi colleghi e battezzare il risorgimento della roots music , il Grande Suono Americano codificato una volta per sempre.
Questo "antico libro dei giovani antenati" si apre con l'indolenza, l'amarezza di "Tears Of Rage", primo paragrafo della storia, con Dylan coautore.
L'elemento a venir fuori è la chitarra elettrica di Robbie filtrata attraverso uno speaker Leslie (altoparlante ad azione rotatoria originariamente concepito per modificare le sonorità dell'organo Hammond, poi sperimentato anche su voce e altri strumenti) che ne altera il suono, il tappeto d'organo di Garth e lo splendido lavoro di batteria di Levon, uno dei più grandi e sottovalutati batteristi di sempre. La voce di Manuel, a metà strada tra sentimentalismo e depressione da "grande freddo", inizia a inquadrare un conflitto padre-figlio. La faccenda sembra prendere una brutta piega: il desiderio di riconciliazione trascolora in risentimento, la rabbia per un dialogo tardivo e non favorito è evidente. Il figlio, un "homo novus" originale dell'America democratica, è alla ricerca di sé stesso, dell'amore e dell'amicizia dei suoi simili. La delusione del genitore è ineluttabile, punteggiata dal pianoforte e dal bel lavoro di ricamo dei due sassofoni nella seconda strofa. La festa dell'indipendenza evocata nel testo è rovinata dall'addio, ma è l'America intera a piangere lacrime amare, la patria afflitta dalla guerra.
Il dolore del padre continua in "To Kingdom Come", nient'altro che una riflessione zen sulla morte: l'anziano ammonisce le nuove generazioni a non commettere errori, a non rivelare anzitempo le proprie carte. Le parti vocali sono affidate alla gracchiante, stridula verve di Robertson, con Richard nei controcanti. Il tono è ironico e scherzoso, più naif rispetto al precedente. Il ritmo è girotondo vorticoso, con un bel ritmo dettato dal piano. Il vitello dorato è il primo di una serie di inquietanti figure bibliche e mitologiche a tormentare il sonno di Robbie, con Manuel l'autore principale dei testi: in questo caso la bestia è fuori della finestra e squadra minacciosamente il malcapitato vecchietto. "In A Station", annunciata dal piano elettrico e dal clavinette, è un'altra stupenda prova del "loner" Richard Manuel: si tratta di un'onirica ballad annacquata ancora di tristezza e senso d'abbandono.
C'è una gran voglia di nascondersi tra la folla e scomparire, immedesimarsi con chiunque si incontri per strada. Purtroppo il desiderio "cristiano" si scontra con il sospetto, la divisione di una società che smette di credere nell'amicizia.
Per quanto lui si sforzi (ancora un riferimento al frutto proibito dell'Eden), non c'è possibilità: ecco allora insoddisfazione e senso di debolezza. Il brano gioca tutto su questo senso di sospensione angelica.
Il "road trip" del protagonista si fa più reale con "Caledonia Mission", amarcord di un amore sfiorito. Il timone della storia lo prende Rick Danko: una ragazza di buona famiglia ebraica vive soddisfatta e autoreclusa in una missione del Sud. Viziata e conservatrice, non ha il coraggio di abbandonarsi alla fuga promessa dal musicista romantico e lavora infaticabile e prigioniera del suo giardino, del suo cancello chiuso a chiave. Il brano prende corpo e si infiamma nel ritornello, in cui si aggiunge anche Manuel ai backing vocals . Per quanto le voci si intreccino con vigore, unite a piano ed elettrica, la prospettiva ipertestuale non cambia.
Il centro, il messaggio di tutto l'album è racchiuso in "The Weight", edito anche a 45 giri, unico hit in carriera, poi inserito nella colonna sonora di "Easy Rider". Qui basterebbe la musica: apertura di chitarra acustica, pochi inimitabili arpeggi e ingresso ("Ba-dum-badum-dum") della batteria. Quindi il pianoforte e le voci. Nel mezzo splendidi cori a tre, fragili ed effimeri come un soffio di vento. E' la parafrasi del sound: artigianale, immediata, costruita sul felice equilibrio di pochi ingredienti azzeccati. Nell'Antico Libro c'è spazio per tutti, si lavora in squadra come provetti boy-scout. L'allucinazione dei testi è comica: gli incontri dell'eroe pellegrino (un po' Gesù Cristo, un po' Paperino o Don Chisciotte) a Nazareth in cerca di riposo e rifugio. Da notare la volontà del protagonista di assorbire senza interessi il dolore della gente, togliere il peso della vita dalle schiene stanche della società. La risposta ancora negativa, è tuttavia gestita con ironia e fatalismo.
La seconda metà dell'Antico Libro insiste sui temi enunciati all'inizio, sfumando e perdendo un po' del sapore nel finale. In "We Can Talk", un mid-tempo gospel sorretto da organo e piano/batteria, torna in scena il conflitto, ora tra coetanei: al posto dell'amata, un amico schiavo dell'opprimente condizione di lavoro. Il consiglio è ripensare a ciò che si è fatto, convincendosi che non è mai troppo tardi, ché il dialogo favorito nel titolo può sbaragliare l'aratro, le mucche e il giogo di un padrone ignorante.
Caso a parte è "Long Black Veil", unica cover del lotto (hit country per Lefty Frizzell nel '59, idolo di Robertson). L'atmosfera lugubre da murder ballad è reinterpretata senza pathos, in un'inedita chiave rilassata, con armonie vocali che crescono e la bella alternanza di tastiere e chitarra acustica. Solo un sinistro bordone di basso-tuba (?) incrina le onde.
La parte migliore della sfrenata "Chest Fever" è l'inizio, un'occasione per Garth Hudson di mostrare il proprio talento: infernale incipit di organo hammond, un virtuosismo da mosca bianca (che ricorderanno i Led Zeppelin al momento di incidere "Your Time Is Gonna Come") verniciato su impalcature, come abbiamo visto, piuttosto corali. Nel testo, così come nel dolcissimo slow tune "Lonesome Suzie" che seguirà, ennesimo tentativo di salvataggio eroe/principessa in pericolo. In "Fever" è la femme fatale autolesionista e distruttrice, una belva feroce da far tremare le ginocchia; "Suzie" è la solitaria-triste-anziana zitella bisognosa di calore umano. In entrambi i casi, la soluzione adottata dal protagonista è la medesima: fuga, libertà, nuova vita.
Peccato per gli ultimi due numeri, scritti in combutta con Dylan: si perde un po', come detto, l'unità narrativa, oltre agli arrangiamenti, sofferenti nel doversi confrontare troppo agli originali già in cantiere ai tempi dei "Basement Tapes". "This Wheel's On Fire" si distingue per l'arrembante tempo veloce, le armonie e l'affilata elettrica di Robertson. L'angoscioso testo minaccia un nuovo incontro tra nemici, due immaginari pistoleri nell'attesa di affrontarsi prima della fine, prima che il buio e la distruzione avvolgano ogni cosa. Il commiato di "I Shall Be Released", cantato da Manuel, riassume coi toni della "torch song" le fila del discorso: l'insanabile dicotomia debolezza/speranza, le distanze del cuore da colmare, il bisogno di dare e ricevere amore (simboleggiato nel brano dalla luce), la libertà come chimera da afferrare con un ultimo, titanico sforzo.
Riesci a immaginarti quella notte di tanti anni fa: l'illuminazione fioca delle candele, la cantina polverosa, cinque tempestosi Heatcliff con barba, cappelli e quel sorriso amaro capace di sgretolare la più dura delle rocce. "Any Day Now, Any Day Now, I Shall Be Released"…
A forza di cantare ed eccitarsi, commuoversi, è scesa la notte. Silenzio nelle verdi vallate di Woodstock, la luna si nasconde e le stelle giocano la solita gara di bellezza. Non un alito di vento, soltanto i gufi tra gli alberi secchi, il fiume che scorre, le foglie sul terreno asciutto. Da qualche parte, nelle vicinanze, l'uomo che un tempo chiamavano Dylan smette di scrivere a macchina. I suoi bambini dormono, è troppo tardi per cercare una melodia alla chitarra. L'album cui sta pensando sarà un'altra rivelazione: Johnny Cash, country-rock, voce morbida.
Parole inedite che escono piano dalla sua mente e si confondono in una nebbiolina di mercurio e argento vivo, eccitandolo. Ma è ora di dormire, domani è un altro giorno, non si sa mai. Via i vestiti, gli occhialini, le scarpe. L'ultimo sguardo assonnato è per un mucchio di negativi sparsi sulla scrivania di legno, lasciati lì da un amico fotografo. Sono le foto dei suoi amici della Band. La preferita, nemmeno a dirlo, riguarda una vecchia panchina scalcinata. "Quel bastardo è maledettamente bravo", esclama, prima di avvolgersi nelle lenzuola. "Devo assolutamente lavorarci".
Extra : musica influenzata dalla Big Pink: Fairport Convention, "Liege & Lief" (stesse premesse della Band, con la voglia però di riscoprire le proprie di radici, traghettandole nella vecchia Inghilterra vittoriana); The Byrds, "Sweetheart Of The Rodeo"; Rolling Stones, "Beggar's Banquet"; Elton John, "Tumbleweed Connection"; Grateful Dead, "Workingman's Dead" o "American Beauty"; Paisley Underground versante Green On Red; Alt. Country di sponda Uncle Tupelo, poi Wilco, Jayhawks, Lambchop. Insospettabili come Eric Clapton o Procol Harum, rei confessi del calibro di Will Oldham o Mercury Rev, superstar come Ryan Adams o Norah Jones. E la lista potrebbe essere lunga più del Mississippi, molto più di quei quarantadue minuti che, a questo punto, avrete una matta voglia di riscoprire.
http://www.ondarock.it/pietremiliari/band_music.htm |
  22/04/2007 10:46 22/04/2007 10:46 |
|
|
Deep Purple - Made in Japan (EMI 1972) Hard-Rock 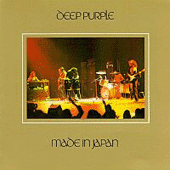
TRACKLIST:
1. Highway star
2. Child in time
3. Smoke on the Water
4. The Mule
5. Strange Kind of Woman
6. Lazy
7. Space truckin'
Autore: Cosimo Chiaramonti
Quando l’amico Samuele Boschelli mi ha parlato della possibilità di iniziare a collaborare con Rocklab, mi sono subito domandato quale sarebbe stato, in ipotesi, il disco che avrei voluto recensire per primo.
Trattandosi della mia recensione numero 0, mi è venuto naturale pensare che avrei dovuto iniziare da un disco basilare, sia per la mia personale formazione musicale, sia, naturalmente, per il genere di cui sarei stato eventualmente chiamato ad occuparmi all’interno di Rocklab.
Ebbene, mi ci sono voluti circa dieci secondi per visualizzarlo.
Si tratta di 'Made in Japan' dei Deep Purple. Il perché è fin troppo ovvio.
Questo è forse il disco rock più famoso della storia oramai ultracinquantennale del genere, di cui, senza ombra di dubbio alcuno, costituisce uno dei pilastri fondamentali.
Ma non solo. L’opera in questione è, prima di tutto, il manifesto di un’epoca, e di un modo di concepire la musica, in particolare quella dal vivo, che, purtroppo, non esiste quasi più.
Sì, perché quando i Purple salivano sul palco niente era scontato o banale. Le loro esibizioni live, così come quelle di molti altri grandi gruppi degli anni ’70, erano completamente lasciate all’estro dei musicisti, alla loro voglia di improvvisare, di continuare a “creare”, anche sul palco.
La leggenda di questo disco è tutta qui, in ciò che è inaspettato, imprevedibile e “straordinario”, nel significato letterale del termine.
La leggenda di questo disco é negli impareggiabili duelli chitarra/voce di “Strange kind of woman”, e nella coda di “Smoke on the water” (conoscete una qualsiasi cover band del gruppo che non la riproponga in questa versione?), è nel lunghissimo assolo di batteria contenuto in “The Mule”, nella pazzesca introduzione di organo distorto di “Lazy”, negli estemporanei assoli di chitarra di Ritchie Blackmore, sempre incredibilmente in bilico tra ricercate melodie barocche e minimali fraseggi blues, nella urla di un indiavolato Ian Gillan.
Credo che potrei continuare all’infinito, ma mi fermo qui. Inutile dilungarsi nel raccontarvi di ciò che sicuramente già conoscete tutti a memoria.
Questa recensione, infatti, non intende essere una sorta di “guida all’acquisto”, dal momento che sono fermamente convinto del fatto che tutti voi che, come me, oramai avete superato i trenta, custodite gelosamente una copia di cotanta opera all’interno delle vostre collezioni (non potrebbe essere altrimenti!)
Questa recensione vuole essere semplicemente un piccolo ma assolutamente doveroso omaggio da parte di un semplice appassionato, ad un’opera grandissima, posta quale pietra angolare alla base di quel meraviglioso edificio chiamato rock’n’roll.
Ai più giovani, che fossero tentati di snobbare un disco del genere, voglio solo ricordare che anche il castello più imponente, senza solide fondamenta, è destinato a crollare miseramente.
A buon intenditor…
http://www.rocklab.it/recensioni.php?id=1754 |
  22/04/2007 19:48 22/04/2007 19:48 |
|
|
I deep purple mi piacciono molto! |
  23/04/2007 18:55 23/04/2007 18:55 |
|
|
|
  30/04/2007 15:46 30/04/2007 15:46 |
|
|
Janis Joplin - Pearl (Columbia 1970) Blues Rock 
Tracklist:
Move Over
Cry Baby
A Woman Left Lonely
Half Moon
Buried Alive In The Blues
My Baby
Me And Bobby McGee
Mercedes Benz
Trust Me
Get It While You Can
Janis Joplin appartiene alle grandi vite bruciate dal rock. Ma mai come in questo caso si può parlare di una commistione pressoché totale tra vita e musica. Janis Joplin è poco più che la sua voce e la sua disperazione. Accompagnata da vari complessi (Big Brother & The Holding Company, Kozmic Blues Band e per ultima la Full-Tilt Boogie Band) nel corso della sua (breve) carriera si è servita del blues-rock come mezzo più fruibile e immediato (e anche più adatto) per dar sfogo alle sue frustrazioni, al suo essere incompresa e alla sua insoddisfazione, dando vita a performance incendiarie, ululanti, con la voce che si piega, si rabbonisce, sbraita, si fa dolce, è sempre sul punto di morire, ma continua a gridare, struggente, melodrammatica, autocompiaciuta. E' la voce di chi si sente sola, di chi in quel corpo c'è finita per sbaglio.
Il 3 ottobre 1970 muore a 27 anni per overdose, dopo aver raggiunto la consacrazione prima al festival di Monterey nel 1967 e poi a Woodstock nel 1969. Postumo, a meno di un anno dalla scomparsa esce "Pearl", disco che era in cantiere con la Full-Tilt Boogie Band, lavoro più rappresentativo e punto più alto della produzione dell'artista texana. Lo apre "Move Over", uno dei pochi pezzi scritti dalla stessa Joplin. E' blues-rock, acido, sguaiato, pestato. La band è in grande evidenza (e ottima forma), batteria a scandire il passo, chitarra a intonare la melodia, la voce della Joplin che si rompe a ogni frase, poi piano, basso e organo incendiario la lanciano su, su, fino a sfuocare, sempre più rotta. E' l'emblema di come un pezzo canonico per quanto di buona fattura viene trasfigurato (e nobilitato) dall'interpretazione della Joplin.
"Cry Baby" è la canzone più famosa del repertorio, ed è anche la migliore: un gospel in cui tutto lo smarrimento e la rabbia vengono letteralmente sputati fuori. I crescendo di piano e batteria fanno da preludio e accompagnano le urla dell'interprete che aggredisce il mondo (e il pubblico che ha di fronte, che lo incarna), pur senza avere la forza di vincerlo. "Cry Baby" è un rituale, è una catarsi: è il corpo che prende possesso di sé e urla fino a distruggersi, finché non resta solo il silenzio a rimbombare in uno spazio vuoto.
In "A Woman Left Lonely", retta dalle tastiere (piano e organo), con la band che si limita ad accompagnare, si può ravvisare una fonte di ispirazione per le canzoni di "Tapestry" di Carole King (che uscirà poco dopo): ma ancora una volta a fare la differenza (stavolta di tono più che di qualità dato il livello, anch'esso molto alto, del disco della King) è la voce che urla, si strazia, si dispera: le canzoni di "Pearl" sono cammini in cerca di redezione. Con "Half-Moon" torna il blues-rock più classico, con percussioni alla Santana a fare da compagne di viaggio. Il pezzo può fregiarsi di uno dei ritornelli (ancora una volta scandito dal piano) più indovinati della carriera della Joplin. Il finale invece, con saliscendi di musica e voce è valore aggiunto (a valore).
"Buried Alive In The Blues" è una strumentale acida, con guizzi di chitarre e organo, di buona fattura, ad alto ritmo: accade però che paradossalmente è proprio quando gli strumenti divengono unici protagonisti (come nei vari assoli della band) che le cose si fanno meno interessanti. Una paradisiaca cascata di note di piano e organo con contrappunto di chitarra aprono "My Baby", che una melodia, certo non da meno, trascina in un coro gospel immortale con la roca, grezza e ancor più struggente leader a conferire momenti di pura religiosità al tutto. Attraverso la rivisitazione di "Me And BobbyMcGee", che guadagna parecchio in fatalismo, si prosegue quella strada verso la redenzione fino a giungere così a una tappa fondamentale, ovvero "Mercedes Benz". Una preghiera per sola voce e con le mani che tengono il tempo, durata due minuti scarsi. La Joplin chiama tutti a intonarla con lei ("everybody") ma l'unica voce che risuona è la sua. Praticamente un testamento. Prosieguo migliore dell'eterea (ancora una volta è il piano a determinare l'effetto) "Trust Me" non poteva essere concepito. E' la canzone più aperta del disco e con essa la Joplin, anziché urlare al (contro il) mondo, si concede, tenera.
Chiude il tutto "Get It While You Can", epica, con la voce che trova in sé il suo rilancio, la sua forza, mentre la band amalgamata la sospinge, la innalza (si può sentire anche una chitarra sempre più acuta, alla Verlaine, circa un minuto, minuto e mezzo prima del gran finale) e la porta in cielo. Dove tuttora, a oltre trent'anni di distanza risiede.
di Ciro Frattini
http://www.ondarock.it/pietremiliari/joplin_pearl.htm |
  30/04/2007 22:56 30/04/2007 22:56 |
|
| | | OFFLINE | Post: 6.169
Post: 283 | Registrato il: 03/12/2003
Registrato il: 11/04/2007 | Età: 56 | Sesso: Maschile | | | |
|
Uhmmm... E di "Sgt. Pepper's Lonley Hearts Club Band" dei Beatles ne vogliamo parlare?
per me quello rimane in assoluto uno dei capolavori del secolo scorso! ![[SM=x322213]](http://www.chatitaliachat.it/serpe/varie/196.gif)
|
  01/05/2007 07:12 01/05/2007 07:12 |
|
|
The Beatles - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (Emi 1967) 
Tracklist:
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
With a Little Help from My Friends
Lucy in the Sky With Diamonds
Getting Better
Fixing a Hole
She's Leaving Home
Being for the Benefit of Mr. Kite
Within You, Without You
When I'm Sixty-Four
Lovely Rita
Good Morning, Good Morning
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)
A Day in the Life
E' il 1 giugno 1967, da questo momento la musica pop cambia definitivamente aspetto e contenuti: esce "Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band", ottavo album dei Beatles in cinque anni. Si può capire tutti i tratti rivoluzionari di questo lavoro solamente ascoltando la musica di quegli anni; basti ascoltare il rock'n' roll americano anni '50 e il beat inglese dei primi '60, suo figlio legittimo. Con Sgt. Pepper's i quattro ragazzi di Liverpool si permettono di rigirare come un guanto la musica contemporanea senza alcuna avvisaglia negli album precedenti. Parafrasando tematiche politiche, si potrebbe dire che hanno condotto un colpo di stato, instaurando un regime agli antipodi col precedente senza che la popolazione si accorgesse di quanto stava accadendo, senza vedere soldati e carri armati per strada. E' il primo concept-album di successo della storia del rock: c'è un filo conduttore, infatti, che rende il lavoro unitario e logico.
Siamo in un teatro... brusio degli spettatori... l'orchestra accorda gli strumenti in sottofondo (sublime!), sta per iniziare lo spettacolo, attacca il primo pezzo dal titolo omonimo all'album. A suonare non sono i Beatles ma la Sgt. Pepper's Club Band che si presenta al pubblicocon un brano rockeggiante e divertente e al termine lancia Billy Shears (Ringo Starr) nel pezzo successivo "With a little help from my friends"; da notare che tra le due tracce non c'è pausa, ma un continuum, e da sottolineare, oltre a due versi enigmatici di Lennon - "What do you see when you turn out the light/I can't tell you, but I Know it's mine" - l'adozione di una forma prossima al dialogo, quasi un'intervista.
Segue un pezzo storico di Lennon: "Lucy in the sky with diamonds", divenuta celebre perché qualcuno lesse tra le righe la sigla LSD, ipotesi che è avvalorata dal testo fantastico in una tessitura narrativa fatta di immagini, tipiche delle visioni acide di chi ha fatto uso di sostanze allucinogene. Una canzone che diverrà nella memoria collettiva una sorta di affresco dell'era psichedelica, superbamente sottolineato dal video a cartoni animati di "Yellow Submarine".
McCartney firma le successive "Getting Better" e "Fixing a Hole", entrambe ispirate da eventi della realtà quotidiana, anche quest'ultima fu soggetta a interpretazioni in chiave "stupefacente" a causa del verbo "fix" che in slang indica il bucarsi. "She's leaving home" è anch'essa frutto della penna di McCartney: lo spunto fu preso da una notizia del Daily Mirror sulla fuga di casa di una ragazza; McCartney ne fece una canzone sulla solitudine (molte analogie con la "Eleanor Rigby") e sulla incomprensione generazionale, un tema assai sentito in quegli anni; i versi sono di grande impatto emotivo e si arricchiscono di una vena amaramente sarcastica, grazie ai contrappunti del ritornello, e agli accorati commenti dei genitori, opera di Lennon.
La genialità di Lennon viene ancora a galla con "Being for the benefit of Mr. Kite!", con il testo ripreso da un manifesto circense dell'età vittoriana; la musica è coinvolgente e trascinante e si sviluppa come una spirale che lascia stordito, disorientato:sembra quasi di essere trasportati all'interno della pista mentre tutt'intorno si esibiscono giocolieri, clown e artisti circensi. L'unico contributo di George Harrison all'album è "Within you without you", un pezzo senz'altro distaccato dal resto dell'album, non solo stilisticamente, ma anche perché vi parteciparono sopratutto musicisti esterni, specialmente indiani, suonatori di sitar; l'esperienza legata alla meditazione trascendentale è dichiarata, Harrison, infatti, è rimasto fino alla sua morte un convinto praticante della cultura orientale.
Decisamente particolare è l'atmosfera di "When I'm sixty-four", in stile vagamente cabaret anni 50, con un basso molto secco e una tuba in sottofondo che sottolinea i versi. La canzone venne dedicata al padre di McCartney, che aveva appena compiuto 64 anni. Dello stesso McCartney è "Lovely Rita", anche in questa occasione l'ispirazione era venuta dalla vita reale, da un'addetta ai parchimetri che lo aveva multato qualche mese prima: nacque così la storia d'amore sbocciata sul luogo della contravvenzione. Lennoniana è invece "Good Morning, Good Morning" ispirata dalla pubblicità dei Cornflakes Kellog's, la realizzazione del brano procedette accumulando elementi e ponendoli secondo l'idea di ricostruire la storia di una giornata, non senza riferimenti criptici.
La penultima traccia è uno degli elementi più caratterizzanti del disco, è la cosiddetta "reprise"; che verrà utilizzata da tantissimi altri gruppi in seguito e che dà un senso di continuità all'album; è la ripresa del brano d'apertura con un testo differente eccettuato il ritornello. E' un fulmine a ciel sereno, un "coupe de theatre" costruito intelligentemente e senza il quale l'intuizione dell'album avrebbe perso consistenza.
La Sgt. Pepper's Club Band torna sul palco per congedarsi dal suo pubblico e per ringraziarlo per essere intervenuto, il pezzo finisce tra gli applausi ai quali si attacca il capolavoro di tutto l'album, "A Day in the Life", che vede la luce dal dualismo Lennon/McCartney. Una chitarra acustica apre su un testo che si snoda con una struttura insolita, una sequenza di nuclei narrativi sviluppati secondo un'idea circolare; è la parte scritta da Lennon, che si ispira a un fatto realmente accaduto, ovvero la morte di un deputato della camera dei Lords in un incidente stradale. Naturalmente il tutto è rivisto nel tipico non-sense lennoniano, aggiungendo riferimenti al suo film antimilitarista "How I Won The War". Alla fine della strofa, scompare la base ritmica originaria, sostituita da un magnificente crescendo di orchestra che si conclude con un pianoforte che batte un tempo più veloce della prima parte, la voce di McCartney si inserisce e spezza il tema precedente in una atmosfera più rarefatta, fumosa, che rende benissimo il relativo testo.Il ritmo, swingeggiante e leggermente "in levare", segna un senso di dinamicità e rottura rispetto al precedente, ma riesce magicamente a ricondurlo senza forzature e contraccolpi all'interno della ritmica originale in cui si svolge l'ultimo verso, ancora cantato da Lennon. Segue quindi, ancora una volta, il crescendo orchestrale, che arrivando allo spasimo si conclude con un accordo di pianoforte suonato violentemente che scema in dissolvenza. Una dissolvenza di moltissimi secondi a cui si dovette lavorare per giorni, dal momento che non esistevano diavolerie elettroniche per produrre quello che oggi puo' fare chiunque, anche con le tastierine per bambini, ma che allora richiedeva moltissime ore di lavoro, di ingegno e di intuizioni. Nonostante ciò, non sempre il risultato è perfetto. A un ascolto attento, verso la fine della dissolvenza quando il suono si affievolisce, si sente un fruscio di fogli e lo scricchiolio di una sedia, rumori che i tecnici non sono riusciti a eliminare nel mixaggio finale.
L'album non si conclude così, alla fine di questa dissolvenza si può ascoltare un fruscio più marcato, ultrasuoni avvertibili solo dagli animali, e dopo questo fruscio arriva un "loop" di suoni e voci senza alcun significato; questo loop era stato inserito nel solco di uscita del disco in vinile. Questo espediente avrebbe consentito a chi possedeva un giradischi vecchio modello di sentire il suono ripetuto all'infinito finché qualcuno non avesse tolto la puntina dal disco, e a chi possedeva un giradischi più moderno di ascoltare un'esplosione di suono pronta a interrompersi quando la puntina tornava automaticamente al suo posto, alla fine del disco. Sul formato cd si può ascoltare solo qualche secondo di questo loop, che poi viene dissolto.
"Sgt. Pepper's" esprime appieno il clima di cambiamento e di anticonformismo che si viveva in quegli anni, i Beatles stravolsero ogni regola e con questo album rivoluzionarono anche il lavoro in studio di registrazione che divenne lungo ed estenuante, ma originale e creativo come mai prima era accaduto.
I testi abbandonano le tipiche tematiche adolescenziali e il sempre verde binomio "cuore-amore" per affrontare temi introspettivi, rapporti con i fan, esperienze "metafisiche" ed eventi direttamente vissuti dai protagonisti o riscontrabili nelle cronache dell'epoca.
E' opinione comune, ed empiricamente verificabile, che da allora nulla suonò come prima:non esisteva questo tipo di elettronica applicata alla musica, e trovare suoni nuovi, "far suonare una chitarra come un piano e un piano come una chitarra" (John Lennon) era un' impresa assai ardua. Per esempio, per creare una voce diversa venivano immersi i microfoni dentro bottiglie d'acqua piene, oppure si cantava in posizioni scomode, così da comprimere la cassa toracica e ottenere una voce del tutto peculiare. Fa poi il suo ingresso in pompa magna l'orchestra applicata al contesto pop-rock, sulla falsariga di quanto già sperimentato (ma con risultati assai meno entusiasmanti) dai Moody Blues: il crescendo di "A day in the life", infatti, fu realizzato da ben 160 elementi.
Anche la copertina è significativa: una copertina completamente a colori e distribuita nella stessa versione in tutto il mondo (era una rarità all'epoca); il termine "album" è coniato proprio per "Sgt. Pepper's" e da "Sgt. Pepper's", il disco infatti si apre come un album fotografico e al suo interno sono presenti foto, testi e addirittura gadget. La foto della frontcover è piena di riferimenti più o meno criptici: i Beatles hanno voluto dietro di sé i personaggi che avevano segnato la loro vita, ma non mancavano molti riferimenti inquietanti quali Timoty Leary (il teorico dell'LSD), Adolf Hitler, Aleister Crowley (il padre del satanismo moderno) e le piante che cingevano la scritta Beatles ai loro piedi erano piantine di marijuana.
Una produzione senza precedenti, insomma, sia dal punto di vista estetico sia da quello contenutistico. Un'accuratezza e una precisione nei particolari che non era mai stata vista in un prodotto di intrattenimento "popolare" destinato al consumo di massa. Con "Sgt. Pepper's" la musica pop si sdogana finalmente dal ruolo marginale, accessorio e meramente leggero che l'aveva caratterizzata fino ad allora ed entra a pieno titolo nelle forme dell'opera d'arte.
di Alessandro Sessa
http://www.ondarock.it/pietremiliari/beatles_sgt.htm |
  01/05/2007 07:14 01/05/2007 07:14 |
|
|
Scritto da: guidozz 30/04/2007 22.56
Uhmmm... E di "Sgt. Pepper's Lonley Hearts Club Band" dei Beatles ne vogliamo parlare?
per me quello rimane in assoluto uno dei capolavori del secolo scorso! ![[SM=x322213]](http://www.chatitaliachat.it/serpe/varie/196.gif)
Un capolavoro del secolo scorso ancora oggi attuale !!!
Anche se io preferisco il 'White album'. |
  01/05/2007 14:18 01/05/2007 14:18 |
|
| | | OFFLINE | Post: 6.169
Post: 283 | Registrato il: 03/12/2003
Registrato il: 11/04/2007 | Età: 56 | Sesso: Maschile | | | |
|
Scritto da: ziva 01/05/2007 7.14
Un capolavoro del secolo scorso ancora oggi attuale !!!
Anche se io preferisco il 'White album'.
Non saprei... Forse preferisco Sgt. Pepper's, ma se la battono... In quel periodo erano al massimo secondo me!
![[SM=x322218]](http://www.vocinelweb.it/faccine/felici/felici-set1/17.gif)
|
  18/05/2007 18:15 18/05/2007 18:15 |
|
|
Van Morrison - Astral Weeks (Warner 1968) Pop Rock 
Tracklist:
Astral weeks
Beside you
Sweet thing
Cyprus Avenue
The way young lovers do
Madame George
Ballerina
Slim slow rider
Ho scoperto "Astral Weeks" due volte: dopo i primi ascolti mi è sembrato bello ma un po' distante, e ho finito per posteggiarlo in panchina. Una volta rispolverato - per chissà quale motivo - l'ho trovato di una freschezza e di una intensità straordinarie, confermando la regola che a volte è solo questione di indovinare il momento giusto: se il "varco" è aperto e il cuore ricettivo, il gioco è fatto. Dovendo riassumere con una frase un po' scontata, infatti, direi che con "Astral Weeks" ho scoperto, più che un pugno di canzoni straordinarie, una categoria dell'anima.
Il primo lato si apre proprio con la title-track, condotta su un serrato accompagnamento acustico dal quale fioriscono mille ricami di flauto (John Payne), vibrafono (Warren Smith), singulti di basso (Richard Davis), un delicato bordone d'archi e la straordinaria voce di Van "The Man" a portare colori grevi in questo paesaggio bucolico e sdrucciolevole: l'effetto è quello di un incontro epico, una fisicità inguaribile che srotola tutto il suo essere spirituale, alla ricerca (fruttuosa) della linea d'ombra che unisce e separa anima e corpo.
L'introduzione di "Beside You" è un arpeggio breve e misteriosamente intenso (alle chitarre dirigono lo stesso Van Morrison e Jay Berliner), ottimo viatico per questo fantasma folk/jazz in libera uscita, deserto viscoso di sentimenti alla deriva tra fraseggi sciolti di flauto e basso, con la linea melodica randagia in un territorio indefinito, tra le mille direzioni di un canto preda di moti, istinti e pulsioni profonde. Più convenzionale – nel migliore dei sensi possibile – la successiva "Sweet Thing", un folk a rotta di collo eppure delicatissimo, la fiera degli elementi di cui sopra ammansiti da una chitarra incalzante e dal primo emergere significativo della batteria tra una spuma di spazzolate jazzy col cuore in subbuglio: inutile aggiungere che svetta sul tutto la voce di Van, proiettata nel punto stesso in cui l'amarezza incontra il dolce cuore della vita.
E' a questo punto che viene calato il primo dei tre assi dell'album (e il resto – per rimanere in metafora - non va sotto il Re…): è "Cyprus Avenue", la magia di un congegno complesso e leggero, un'intrigo di chitarra, spinetta, basso (strepitoso!), archi sdrucciolevoli e violino roots, la cospirazione del canto immerso nel suo stesso fango sacro, il progredire calmo di un'espressione verso il suo compiersi assoluto.
L'asso numero due segue a ruota, in apertura del (teorico) lato "B", e rischia di sfracellare irrimediabilmente le fragili resistenze del cuore: "The Way Young Lovers Do" è una frenesia boogie/jazz imbastardita da un'attitudine invariabilmente folk, o se preferite una sbalorditiva accumulazione di elementi e fraseggi in libertà attorno a un crescendo melodico irresistibile. Non stupisce che sia stata ripresa dalla magnifica voce di Jeff Buckley nel suo "Live at Sin-è" (e ognuno si schieri per la versione che preferisce): in ogni caso, non è questo l'unico debito che il povero Jeff doveva a Van Morrison.
Riprende un sentiero più pacato la preziosa "Madame George", un etereo dialogo notturno tra innocenza e azzardo, un testo/storia che "monta" un po' troppo sulla musica, anche se ci troviamo al cospetto di un'altra interpretazione vocale da cui nessuno Springsteen di lì a venire ha mai potuto prescindere. Ma è il momento del terzo (meraviglioso) asso, ovvero "Ballerina", una melodia straordinariamente distesa, spaurita da incursioni di mandolino e dall'epilessia dolciastra di basso e drumming, con aeree decorazioni d'archi e i tocchi acquosi di un vibrafono inquieto, per la gioia e il dolore di un Van Morrison gigantesco mentre tesse un indimenticabile filo tra visceralità ed equilibrio, tra speranza, sogno e trepidazione.
L'epitaffio breve e vibrante di "Slim Slow Spider", innervato su un arco sfuggente di sax soprano (Payne), è una nera memoria di blues diluito, una dissolvenza di basso, un caracollare letterario di chitarra, il precipitare repentino della batteria in un buio inevitabile, il ripiegarsi della voce nella quiete disperata e accogliente di un'anima finalmente redenta.
di Nello Giovane
http://www.ondarock.it/pietremiliari/morrison_astral.htm |
  15/06/2007 18:11 15/06/2007 18:11 |
|
|
Clash - London Calling(Cbs 1979) Punk 
Tracklist
London Calling
Brand new Cadillac
Jimmy Jazz
Hateful
Rudie can't fail
Spanish bombs
The right profile
Lost in the supermarket
Clampdown
The guns of Brixton
Wrong 'em Boyo
Death or glory
Koka Kola
The card cheat
Lover's rock
Four horsemen
I'm not down
Revolution rock
Train in vain
Postumamente eletto dalla celebre rivista americana "Rolling Stone" quale migliore disco degli anni 80, sebbene uscito nel dicembre 1979, "London Calling" rappresentò per i Clash l'album della consacrazione. Terzo della formazione londinese, dopo il fortunato "The Clash" e il meno fortunato "Give 'em enough rope", si presentò, infatti, sin dalla sua uscita sul mercato, come un lavoro maturo, ambizioso, destinato a lasciare il segno nei decenni a venire: un doppio Lp prodotto da Guy Stevens e la cui copertina divenne presto celebre. A proposito di quest'ultima, forse non tutti sanno che si tratta di una citazione di quella del primissimo disco di Elvis Presley, datato 1956. Esattamente vent'anni più tardi, nel 1976, nasceva a Londra il movimento "punk" e i Clash erano quei giovani che in una delle prime canzoni cantavano "no Elvis, Beatles and Rolling Stones".
Tre anni dopo, alla fine del '79, però, dopo lo scioglimento dei Sex Pistols, la morte di Sid Vicious, l'approdo del punk negli States, molte cose erano cambiate; i Clash stessi, che di quel movimento erano rimasti gli ideali portabandiera, cominciarono a mutare fisionomia: dismessi gli abiti punk e lasciata alle spalle una certa dose di ingenuità, i quattro non erano più i "city rockers" degli esordi, ma una formazione matura, in grado di guardare al futuro e, forse per la prima volta, pienamente capace di fare anche i conti con il proprio passato ideale, di recuperare le proprie radici musicali, quelle che la rivoluzione del punk aveva negato nella sua radicale contrapposizione a tutto ciò che l'aveva preceduta. Quella rivoluzione si era esaurita prematuramente perché non aveva saputo costruire o, meglio, non era stata in grado di ricostruire dopo aver distrutto; i Clash al contrario, intraprendendo un cammino personale, ci tentarono e probabilmente ci riuscirono: attraverso un recupero critico del passato, cercarono dei valori per motivare il presente, per poterli poi proiettare nel futuro.
Fin da subito, "London Calling" fu visto come un disco epocale, un vero e proprio spartiacque: sembrava idealmente eletto a sancire la fine gli anni 70, decennio ricco di fermenti, proposte, illusioni, fallimenti, e ad aprire la strada a una nuova decade, per molti versi differente. Un'intera generazione di giovani rockers, all'indomani dell'uscita di "London Calling", percepì, forse già con un pizzico di nostalgia, il definitivo tramonto del movimento punk "storico", ossia di quello che, in buona parte, si era identificato esclusivamente con la storia dei gruppi londinesi che l'avevano generato e alimentato: il punk-rock ormai invece, esportato negli USA e avviatosi verso l'impervia strada dell'autoproduzione, diventava qualcosa di diverso da quello che era stato, e un gruppo come i Dead Kennedys, che si formavano in quegli stessi mesi a San Francisco, appariva molto lontano da Strummer e soci, che pure di quello stesso movimento erano stati, inizialmente, tra i maggiori esponenti.
In "London Calling", a dispetto del titolo, la Londra infuocata del '77, quella della "Westway", dei sobborghi, dei mercati e degli scontri urbani, nonostante venga rievocata in alcuni episodi del disco, sembra ormai distante, e dei 19 (all'origine, 18 più uno nascosto, "Train in vain") brani che compongono l'opera, nemmeno uno solo di essi, musicalmente parlando, può essere più definito "punk", secondo l'accezione alquanto stereotipata che il termine venne ad assumere a partire dall'avvento della "seconda ondata". Eppure, nello stesso tempo, è proprio "London Calling" a rappresentare il vero e definitivo frutto maturo del punk britannico: un capolavoro che non sarebbe stato possibile senza quella esperienza e che, pur di essa superandone tutti i limiti, ne traghetta lo spirito essenziale nel panorama rock dei decenni a venire.
E' con questa sospensione tra passato, presente e futuro, che bisogna leggere il disco, a cominciare dalla sua storica copertina e al suo richiamarsi a quella dell'esordio di Elvis. Se messe a confronto, le due cover presentano la medesima grafica adoperata per le parole e gli stessi colori; allo stesso modo, in entrambe campeggia una foto in bianco e nero scattata durante un'esibizione live. Se dunque colpisce questa dichiarata similarità che assume la valenza dell'omaggio a un inossidabile mito americano, dall'altro lato, è proprio l'analogia stessa a mettere in risalto quello che sembrerebbe un contrasto stridente: la foto della copertina ispiratrice ritrae un Elvis mentre canta e suona imbracciando la propria chitarra; l'altra, al contrario, immortala il bassista dei Clash, Paul Simonon, nell'atto di infrangere con rabbia il suo strumento al suolo durante un concerto al Palladium di New York. Un contrasto molto ricercato per significare lo scontro generazionale, quello su cui il movimento punk aveva fondato il proprio credo (e, dunque, ecco motivato il riferimento 1956-1976). Ma, al medesimo tempo, l'intento citazionista porta con sé anche il segno del cambiamento, della maturazione, del cambio di prospettiva: manifesta un desiderio di pacificazione, di riassorbimento del contrasto stesso, che si traduce in un recupero del proprio passato ideale e in una sua rilettura in chiave moderna, tanto da costituire un modello per le generazioni future. C'è tutto questo nella copertina e, forse anche molto altro (come un saggio esemplare del contraddittorio rapporto di odio/amore dei Clash nei confronti degli States); la sua grande efficacia comunicativa è riposta probabilmente proprio nella sua vaga contraddittorietà e nel suo non privilegiare una "chiave di lettura": può essere letta come un tributo ad Elvis e al rock 'n' roll, e sicuramente lo è; ma forse contiene implicita anche una sottile denigrazione nei confronti di un "sacro" del rock americano e quindi dell'immaginario collettivo statunitense? Oppure, perché no, possono esser vere entrambe le cose insieme: da qui la complessità e, dunque, il fascino di quell'immagine; il suo oscillare tra passato, presente e futuro, come i Clash stessi in quei mesi di transizione. Ma, allorché "London Calling" assunse ben presto lo spessore di un vero classico del rock, la stessa copertina finì per diventare, paradossalmente, più famosa e addirittura più "classica" dell'ispiratrice.
Con "London Calling", per la seconda volta (dopo aver nel '77 firmato per la Cbs), i Clash si trovavano di fronte una scelta decisiva la quale, se allontanò i vecchi fan più oltranzisti, che si sentirono traditi da una band accusata di esser divenuta "conservatrice", di essersi venduta al mercato e di aver assunto atteggiamenti da rockstar, si sarebbe dimostrata pienamente ricompensata non solo dal grande consenso di pubblico e critica che l'album ottenne sia in patria sia all'estero ma, a posteriori, dalla sua longevità, dalla sua modernità e dalla grande lezione che se ne trasse. Se "London Calling" venne accolto come un capolavoro, basta poco per accorgersi che in questo disco, rispetto ai precedenti, la maturazione della band è davvero notevole: i Clash attraversavano un periodo di straordinario equilibrio, che in parte non avrebbero ritrovato con il successivo "Sandinista!" né, sicuramente, in "Combat Rock", e cominciavano a costituire un valido punto di riferimento e un modello ispiratore per molte formazioni, anche parecchio differenti tra loro, che in quegli anni muovevano i primi passi: a cominciare dai Pogues di Shane MacGowan, fino addirittura agli U2; per poi esercitare la loro influenza, più o meno direttamente, su tanti gruppi degli anni 90.
Seppur sempre molto lontani da qualunque formalismo, i Clash di "London Calling" appaiono notevolmente cresciuti da un punto di vista strettamente musicale; a cominciare, ovviamente, dalla coppia Strummer-Jones che, in questo disco, regala alla posterità molti tra i brani dei Clash migliori di sempre: Joe Strummer vive un grande momento di ispirazione e acquista una sua vena poetica; Mick Jones si dimostra un eccellente compositore con una quasi maniacale cura degli arrangiamenti, oltre che rivelarsi alla voce perfettamente intercambiabile con Strummer: i brani più "pubblici" e militanti sono quelli adatti alla voce di Joe, i momenti più "privati" e intimistici, invece a quella, molto diversa, di Mick. Ma è anche grazie alla solidità della sezione ritmica che i Clash riescono a ottenere i più alti risultati; spesso si trascura l'importanza che, sin dagli inizi, ebbe per il gruppo un batterista come Topper Headon, musicista alquanto tecnico e con una formazione jazz alle spalle, e che in "London Calling" diede anche prova della propria creatività. Al basso, Paul Simonon è maturato anche mediante il contatto con influenze musicali diverse, molte delle quali fu proprio egli a introdurre nel repertorio della band. Infine, in "London Calling" fanno la loro comparsa anche altri strumenti, adesso divenuti indispensabili: primi fra tutti, fiati e percussioni; episodicamente, anche pianoforte e organetto.
Se è quindi evidente che i Clash danno vita ad un album che si distacca dai precedenti, non bisogna però commettere l'errore di vedere, come spesso si fa, una netta cesura con il passato: il gruppo, infatti, non rinuncia a nessuna delle proprie caratteristiche iniziali; matura e si evolve, ma senza mai smentirsi. "London Calling", anzi, è proprio il disco che esalta maggiormente una grande qualità che i Clash hanno sempre posseduto, quella che ha fatto sì che non abbiano mai scritto due canzoni che si assomigliassero tra loro: la varietà. Varietà di timbri innanzitutto, con la già menzionata alternanza alla voce di Strummer e Jones (in alcuni brani, anche con la compresenza di entrambi, in dialogo), e fantasia compositiva. La versatilità che ne deriva è quella che probabilmente costituisce la maggiore risorsa della band, sin dagli esordi e lungo tutto l'arco della sua carriera; a partire da "London Calling", come detto, è semmai esaltata maggiormente: persino il bassista Simonon, infatti, è preposto alla voce in un episodio.
Ma, se nel disco questa varietà "strutturale" della band si accentua, essa poi si sposa egregiamente con un'altra forma di varietà che costituisce la vera cifra stilistica dell'opera. Ciò che veramente affascina in questo album, e che ne rappresenta la novità, è infatti la grande pluralità di generi e sotto-generi, di influenze, ritmi, culture e sotto-culture che vengono messe insieme: si va dal rock "puro", per così dire, di "London Calling" o di "Death or glory", al vulcanico rock'n'roll di "Brand new Cadillac", rilettura in perfetto stile Clash di un originale dei 60 firmato Vince Taylor; dall'autentico reggae di "Revolution rock" e quello clashiano, ma non per questo meno "autentico", di "The guns of Brixton", fino al modernissimo, anticipatore di molte tendenze, palpitante emo-pop di "Lost in the supermarket"; passando per le sonorità jazzate di "Jimmy jazz", per lo ska di "Wrong'em Boyo", per il funk-ska di "Rudie can't fail"; e c'è davvero ancora tanto altro da scoprire tra una canzone e l'altra.
All'interno di uno stesso brano, inoltre, sono presenti tanti "motivi" diversi, a volte anche solo un certo riff o un particolare timbro, come certi lontani riverberi di instrumental-surf in "Brand new Cadillac" e "I'm not down" o certi echi latino-americani in "Spanish bombs", che rendono ancora più difficile, ammesso che sia possibile, una "pura" attribuzione di genere. I generi sembrano infatti fondersi, confondersi, per poi magari scoprire di possedere delle radici comuni, come le possiedono le culture che ne stanno alla base. Il risultato di questa grande varietà non è però, come si potrebbe pensare, una commistione dispersiva, confusa o poco creativa: al contrario, i Clash riescono a sintetizzare una serie di istanze diverse, a coglierne un'anima comune e, rileggendole in chiave moderna, le rendono inconfondibilmente "Clash sound"; né si pensi che lo scopo sia, in alcun modo, un nostalgico "tuffo nel passato": è solo il presente e il futuro che la formazione ha veramente a cuore.
Infine, quella della band non fu certo una scelta dettata da una qualche prospettiva commerciale, come accadde invece per altri gruppi, ad esempio i Police, che, dietro la scia degli stessi Clash, mescolarono sonorità diverse, ma forse più per vendere copie che per un'autentica vocazione. Al contrario, per i Clash non si trattava di una totale novità o un radicale cambio di prospettiva rispetto al passato: fin dagli esordi, infatti, si erano misurati con il repertorio reggae e avevano dato vita, primi in assoluto, a un singolare connubio tra punk-rock e reggae (lo stesso Bob Marley li omaggiò, citandoli in "Punky reggae party"). Adesso, gli orizzonti musicali del quartetto sembravano aprirsi ancora di più: al già sperimentato reggae, si affiancava il recupero del rock'n'roll nella sua vena più genuina, ma anche altre sonorità e influenze differenti tra loro. Non si dimentichi, poi, che i Clash sono stati tra i pionieri nel recupero di generi e sotto-generi nati negli anni 50, e negli anni 70 attraversanti alterne fortune, come il "rockabilly" o lo "ska", e nella loro reintegrazione nel rock contemporaneo, determinando quella commistione di generi molto viva ancora oggi in diversi ambienti rock, alternativo e non.
Quello che è fondamentale è che in "London Calling" i Clash non andavano solo alla ricerca di quelle che ritenevano essere le proprie origini ma, spinti da una passione per l'intero fenomeno "rock" nella sua complessità, ne tentarono addirittura una personale genealogia, recuperandone anche quelle che sono le radici nere e che il punk aveva misconosciuto, generando spesso anche forme di ambiguità politica. In quanto ai Clash, nonostante qualche episodico fraintendimento determinato da rari estremismi e da alcuni atteggiamenti "militaristi", non ebbero mai con sé alcuna ambiguità politica. A dispetto dell'ostilità ricevuta sia da parte dei vecchi punk nostalgici sia dei nuovi punk statunitensi, la formazione non dimenticò mai le proprie origini "dal basso" e non perse il contatto con il proprio pubblico: significativa, tra le altre, la scelta di vendere il doppio lp al prezzo di un normale.
Sul versante dei testi e dell'impegno sociale, poi, i Clash non rinunciarono al proprio caratteristico "realismo", né arrestarono minimamente la propria militanza di band impegnata. Pur non sottomettendo mai le "ragioni musicali", anzi in perfetto accordo con esse, infatti, temi sociali sono presenti in tutto il disco: a cominciare da "London Calling", il brano che, oltre darne il nome, apre l'album; ma che apre anche la strada del decennio alle porte, di cui sembra prevederne molte inquietudini (pochi anni dopo, seppur parecchio lontano, Chernobyl, quell'allucinante e apocalittico "nuclear error" che nella canzone si immaginava, sarebbe diventata triste realtà dando vita a uno dei maggiori disastri ecologici dei nostri tempi); "Spanish bombs", una ballata scandita dal raffinato "duetto" Strummer-Jones, recupera le sbiadite, ma ancora impresse, memorie della guerra civile di Spagna; "The right profile" è dedicata alla memoria dell'attore Montgomery Clift, uno dei "belli e dannati" della vecchia Hollywood; in "The guns of Brixton", il messaggio sociale è affidato alle sonorità del reggae, che in questo brano fa risuonare le sue corde più cupe ed è reso ancora più pregnante e autentico dalla voce del bassista Simonon, nato proprio a Brixton, quartiere londinese simbolo delle lotte della comunità "black"; nella splendida "Lost in the supermarket", affidata invece alla voce di Jones, il delicato ricordo di un'ordinaria esistenza vissuta nel grigiume di una periferia londinese diventa la commossa denuncia dell'alienazione e della solitudine dell'individuo nella società dei consumi e dell'urbanizzazione; l'antiamericanismo di "Koka Kola" è l'altra faccia di quello che è generalmente considerato l'album "americano" dei Clash; "I'm not down", già dal titolo, rende l'idea di quanto sia ormai distante il nichilismo della "blank generation". E la cover di "Revolution rock" affida ancora una volta al reggae l'invocazione per un "rock rivoluzionario". Come lo fu sempre quello dei Clash e, ancor di più, forse proprio nel momento in cui sembrò che voltassero le spalle al passato.
Se la loro rivoluzione non portava più il nome di "punk", era perché quel movimento, nella forma in cui era nato, aveva ormai concluso il suo corso: i nostri non lo rinnegarono, né lo tradirono, ma compresero che, per mantenerne davvero vivo lo spirito, era necessario superarne i limiti, musicali e intellettuali, troppo angusti in cui era stato ridotto. Se però "punk", come alle origini, è chi non accetta le convenzioni e le aspettative che la propria comunità impone, i Clash continuarono a esserlo proprio nel rifiutarsi di accettare una qualsiasi formula standardizzata e limitativa, nel non essere mai quello che ci si sarebbe aspettati, o che si sarebbe voluto, che fossero: dimostrando che l'attitudine va ben oltre la semplice accettazione di un canone, insegnarono che se si ama veramente la musica, non si possono mettere ostacoli di nessun genere al proprio talento. Ecco perché i Clash, che del punk non furono figli ma tra i padri stessi, non considerarono mai questo come un genere o una sottocultura rock, ma dimostrarono invece che, se per alcuni quel movimento era stato solo una "truffa" oppure una forma di cieca distruzione fine a se stessa, per altri invece, per loro, scaturiva da una sincera passione per il rock e dalla condivisione di una serie di valori che esso, ai loro occhi, era in grado di veicolare alle generazioni future, come aveva fatto nei confronti di quelle passate.
Joe Strummer e Mick Jones: due personalità e due talenti diversi per natura, spesso difficili da conciliare, ma che, finché si trovarono uniti in un progetto comune, diedero vita ad una coppia straordinaria, la quale, per diversi motivi, nel rock inglese è paragonabile solo a quella Lennon/McCartney. Quest'ultimo punto deve fare riflettere: se il vero scopo di fondo di quella rivoluzione musicale che, nella seconda metà degli anni 70, prese il nome di "punk" era stato, per molti versi, quello di dar vita a un nuovo rock d'oltremanica che si affrancasse dall'eredità beatlesiana, furono i Clash e solo loro, proprio nella maturazione e nel superamento dello stesso "punk" nei suoi limiti culturali, nei suoi canoni musicali e in tutte le sue contingenze storiche, a realizzarlo veramente. A partire da "London Calling", infatti, dopo l'epoca "d'oro" di Beatles, Stones e Who, i Clash vanno ricordati come quella che è stata, con ogni probabilità, la più importante formazione britannica nella storia del rock contemporaneo.
Alla memoria di Joe Strummer (1952-2002)
di Francesco Paolo Ferrotti
http://www.ondarock.it/pietremiliari/clash_london.htm |
  24/07/2007 23:14 24/07/2007 23:14 |
|
|
Talking Heads: 77 (Sire, 1977) 
Nel 1977 muore Charlie Chaplin, Amnesty International vince il premio Nobel per la pace, muore anche Elvis. Ci sono i Sex Pistols, le Brigate Rosse e il 10 settembre in Francia viene usata per l'ultima volta la ghigliottina. In quello stesso anno esce un disco d’esordio dal titolo lapidario: Talking Heads: 77.
Le "teste parlanti" vengono da New York. Si sono formate nel 1974: David Byrne (voce, chitarra, tastiere, tutto) fonda la band con Chris Franz (batteria), un suo compagno di scuola, a loro si aggiungeranno Tina Weymouth (basso) e Jerry Harrison (chitarra, tastiere). Gruppo di punta di quella new wave che avrà tra i suoi protagonisti anche Patti Smith, Television, Blondie. I Talking Heads sono rockstar con la penna nel taschino, multiformi e curiosi come il loro frontman. Se la spassano con allegra irriverenza senza magliette strappate e slogan nichilisti, con occhiali dalla montatura nera spessa, e un innegabile gusto per il nonsense pseudopostsemidadaista. Colti e pop senza vergogna.
Salgono alla ribalta cavalcando l'onda della nascente scena punk di New York, esordendo nel celebre CBGB's come spalla dei Ramones. La voce di Byrne è singhiozzante e nevrotica come il suono del gruppo, fende l'aria con andatura sincopata pulsando con irriverenza un rock eclettico, che si mescola col funk, e veleggia, leggero e secco come la brezza primaverile di Coney Island verso paesaggi ritmici ossessivi, aperti a ogni sperimentazione. Tribali e metropolitani. Sono la colonna sonora perfetta per quella giungla di metallo, carne, smog e cemento, comici falliti e tassisti psicotici che è New York City.
Lester Bangs descrisse con lucida ironia, in poche sintetiche righe, l'animo del loro leader: "David Byrne ha uno sguardo da manicomio ma non emana un senso di pericolo: sembra solo un simpatico mattacchione che hanno mandato a casa dal reparto psichiatrico con una busta di Torazina".
di Gianni Bianchi
http://delrock.it/articoli/2007-07/talking_heads_77_07.php |
|
|
|
|